 Da quanto tempo non provate una robusta, sana, ruspante invidia sociale? Non intendo una di quelle gelosie tipiche di questi tempi oscuri per la quale tu, disoccupato, provi odio nei confronti del tuo vicino di casa che ha ancora il salario da camionista, ma proprio quel desueto senso anni settanta di appartenenza ad un classe diversa, inferiore.
Da quanto tempo non provate una robusta, sana, ruspante invidia sociale? Non intendo una di quelle gelosie tipiche di questi tempi oscuri per la quale tu, disoccupato, provi odio nei confronti del tuo vicino di casa che ha ancora il salario da camionista, ma proprio quel desueto senso anni settanta di appartenenza ad un classe diversa, inferiore.
Insomma, da quanto non vi sentite Gennarino Carunchio?
A me è capitato la scorsa settimana.
Gradito ospite-Calimero ad una “cena prestigiosa” (si dice così, vero?) nella quale sono stati bevuti vini che definire colossali è un eufemismo, con la mia foga da eno-parvenu ho avventato per primo il naso nel bicchiere di un Margaux 1971 e mi è balzato alla mente De André: “La morte verrà all’improvviso, avrà le tue labbra e i tuoi occhi”, e, ho aggiunto, il tuo olfatto.
TAPPO!
Ho alzato timidamente la manina per comunicarlo agli altri commensali, che hanno concordato: è proprio tappo.
Ora, il mio elenco di smoccolamenti assortiti potete immaginarlo: quando mai ricapiterà a me, Carunchio Gennarino, di sedere nuovamente al desco dei Signori per assaporare il nettare divino? Ingenuamente pensavo però che anche i Re, nel loro piccolo, si incazzassero: è qui che sbagliavo, è qui che ho capito la differenza che corre tra me e gli Onnipotenti ed è qui che si è risvegliato il mio sopito stimolo alla invidia di classe.
Per farla breve, il proprietario della bottiglia non ha fatto un plissé e, con tutta la calma e la serenità del mondo, intercalando tra un discorso e l’altro, ha dichiarato sorridendo: “Pazienza, apriamo Château Ausone ’75”.
Stop. Nessuna litania sui santi o testata contro il muro. Questa è classe, caro Gennarino!
Facezie (insomma…) a parte, l’invito di un amico gentile (che mai potrò ringraziare abbastanza) mi ha permesso di imbucarmi all’evento; ovviamente ci tengo a raccontarvi tutto, così da farvi rodere il fegato alla grande e controbilanciare la mia invidia di cui sopra con un sapiente colpo di karma.
 Pronti via: con gli antipasti abbiamo stappato due Champagne: Salon 1985 e Bollinger R.D. 1988.
Pronti via: con gli antipasti abbiamo stappato due Champagne: Salon 1985 e Bollinger R.D. 1988.
Chi legge il blog conosce forse il mio amore per le bollicine, ma qui siamo fuori scala: intanto vini perfetti, senza ombra di sfregio da parte del tempo, che anzi ha contribuito ad evolvere il profilo gustativo verso vette difficilmente immaginabili.
In entrambi i casi la bolla è ancora vitale e copiosa, ma talmente sottile e delicata da risultare cremosa; Salon in particolare si presenta già dal colore, quasi ambrato, come qualcosa di “altro” rispetto ad un normale Champagne: trasfigurato in una dimensione a sé, nettamente evoluto ma sapido, complesso in maniera imbarazzante, con note che dal miele di acacia arrivano al caseario, passando per la canonica pasticceria. Monumentale.
Bollinger: appena versato parte più tranquillo, più Champagne nel colore e con un corredo aromatico meno ampio (si fa per dire) e meno intenso, ma dalla sua ha maggiore freschezza e mineralità e, nonostante una potenza superiore (immagino regalata dal Pinot nero) è forse più adatto agli antipasti. In ogni caso col passare dei minuti diventa più intrigante: si infittisce la sapidità e si rinforzano la crosta di pane e la mela ed esce un accenno di fungo.
 Con la prima portata è arrivato il signore e padrone incontrastato della serata: Chambertin Clos de Beze 1987 Luis Jadot.
Con la prima portata è arrivato il signore e padrone incontrastato della serata: Chambertin Clos de Beze 1987 Luis Jadot.
Classico colore da Borgogna, scarico ma ancora vivissimo, è soprattutto l’olfattivo ad impressionare: c’è tutto quello che vi viene in mente e anche di più, il piccolo frutto, la terra, il bosco, il balsamico, il selvatico e persino un accenno di agrume maturo. Da manuale AIS sarebbe ampio, molto intenso ed eccellente. Da assaggiatore, chiudi gli occhi e sei in mezzo ad una collina francese. Stop.
In bocca è altrettanto perfetto: è caldo ma l’alcol non si sente per nulla, è fresco ma l’acidità non graffia, e il tannino è lieve e setoso.
Il Pinot nero nella sua massima espressione, una bottiglia aperta credo nel momento di massima grazia in cui nessun elemento spicca o ne sovrasta un altro e tutto si fonde in un insieme per descrivere il quale occorre, una volta tanto a ragione, scomodare il mitico termine “armonico”
In una parola: il Vino con la V maiuscola.
Nota a margine: il problema di una bottiglia del genere è che d’ora in poi ogni altro assaggio uscirà impietosamente demolito dal confronto: dovrò darmi al chinotto o alla aranciata.
 Di Château Margaux e del relativo tappo abbiamo parlato, quindi passiamo a Château Ausone ’75. Vino enigmatico: arriva completamente muto, del tutto chiuso nonostante l’apertura effettuata due ore prima e la seguente scaraffatura.
Di Château Margaux e del relativo tappo abbiamo parlato, quindi passiamo a Château Ausone ’75. Vino enigmatico: arriva completamente muto, del tutto chiuso nonostante l’apertura effettuata due ore prima e la seguente scaraffatura.
Ci vorranno ancora molti minuti e tanti giri di polso per stanarlo: il colore è ancora giovanissimo e concentrato, finalmente escono gli aromi e c’è un sorprendente e nettissimo caffè, poi spezie in quantità e un tannino vivo, ben definito e piacevole.
Interessante, ma siamo ad anni luce dal Clos de Beze.
 Si chiude la partita con gli erborinati, accompagnati da Château Suduiraut 1975.
Si chiude la partita con gli erborinati, accompagnati da Château Suduiraut 1975.
I vini dolci non sono il mio terreno di gioco preferito, ma non posso fare a meno di ammirare la grandezza di questo Sauternes: alla vista colore carico, brillante e densità non eccessiva per la tipologia; al naso tutta la declinazione del muffato nobile, la frutta secca, l’albicocca disidratata, il miele, la frutta tropicale e soprattutto uno zafferano immenso, inarrestabile.
L’assaggio ripropone le stesse sensazioni dell’olfattivo, in più è lunghissimo, di una persistenza oltre ogni confine: trascorsa mezz’ora dopo aver mangiato i formaggi, avevo ancora lo zafferano in bocca…
In conclusione, che dire della serata?
Ho imparato sicuramente qualcosa, in primis che il sentimento dell’invidia mi appartiene e mi consuma nonostante io non voglia, ma a parte questo ho capito che esistono vini di una finezza che fino ad oggi avevo solo immaginato, e che purtroppo sono riservati a pochi, fortunati semi-mortali.
E mi sono accorto che, per noi Gennarini, una batteria di questo calibro è troppo, in particolare se abbinata ad una cena quasi altrettanto sontuosa: tutta questa grazia ti assale e ti sovrasta, e ti rende quasi incapace di capire e di godere appieno: non arrivo ancora a pensarla in toto come Francesca, ma quasi quasi…
Articoli correlati:
 Uno champagne 1er Cru a meno di quaranta euro non è impossibile da trovare, ma certo non capita tutti i giorni.
Uno champagne 1er Cru a meno di quaranta euro non è impossibile da trovare, ma certo non capita tutti i giorni.


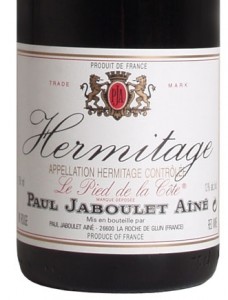

 Potrei scrivere anche che Brewdog non si è fatta mancare le ormai canoniche birre tirate in serie limitata e le altrettanto obbligatorie collaboration beer con altri birrifici in voga, le baruffe con il partito dei tradizionalisti della birra inglese (il solitamente santificato
Potrei scrivere anche che Brewdog non si è fatta mancare le ormai canoniche birre tirate in serie limitata e le altrettanto obbligatorie collaboration beer con altri birrifici in voga, le baruffe con il partito dei tradizionalisti della birra inglese (il solitamente santificato 









