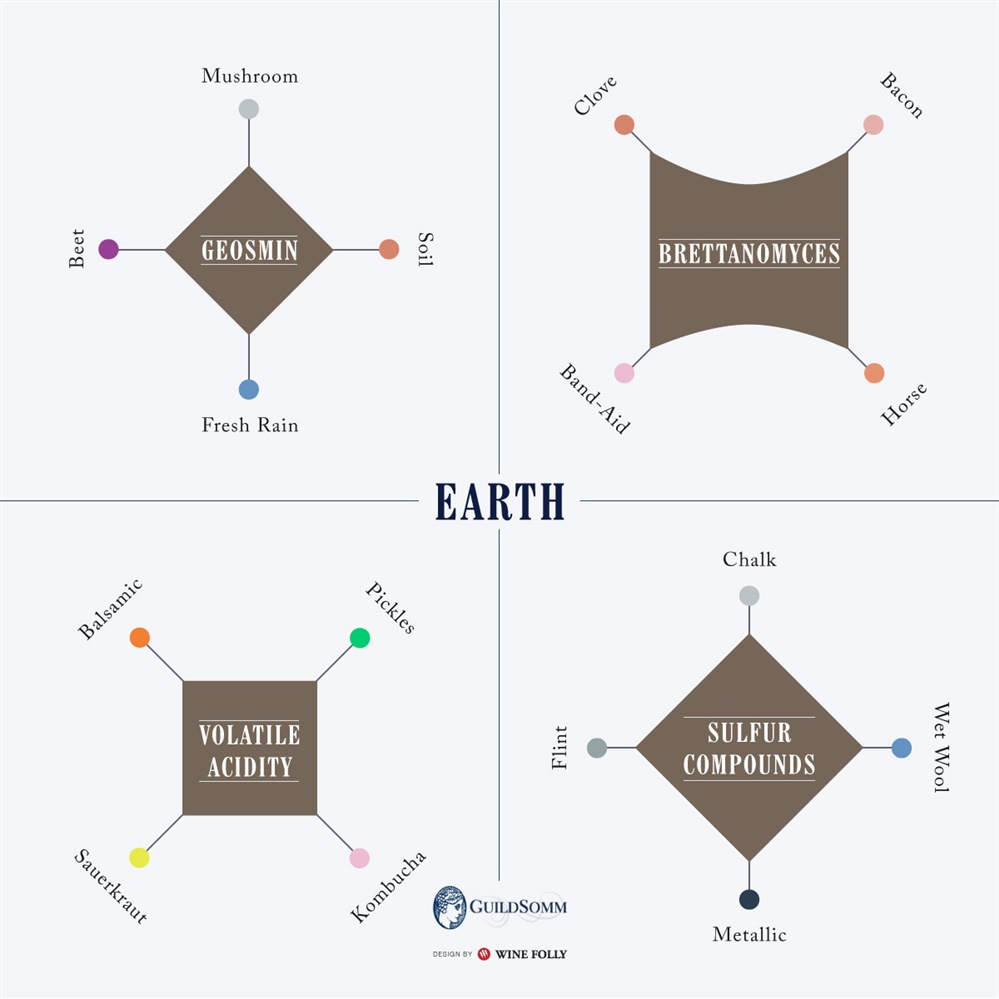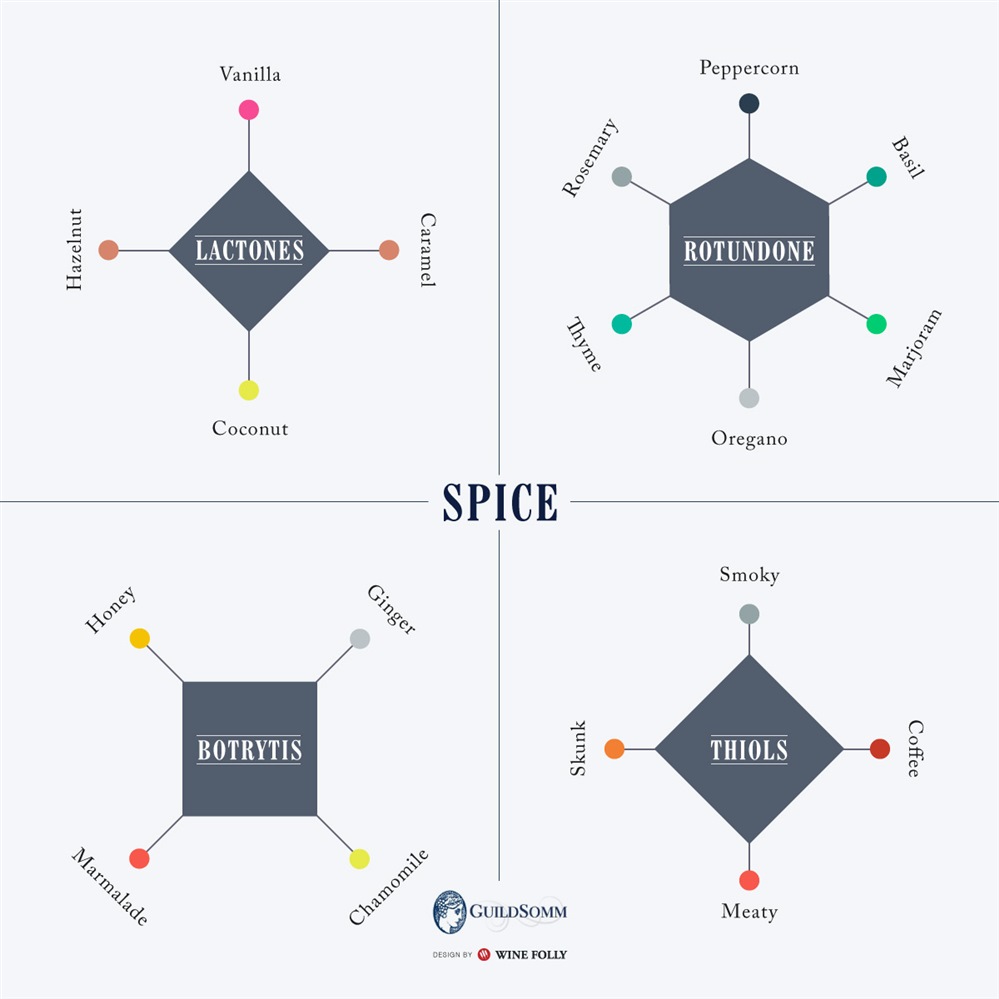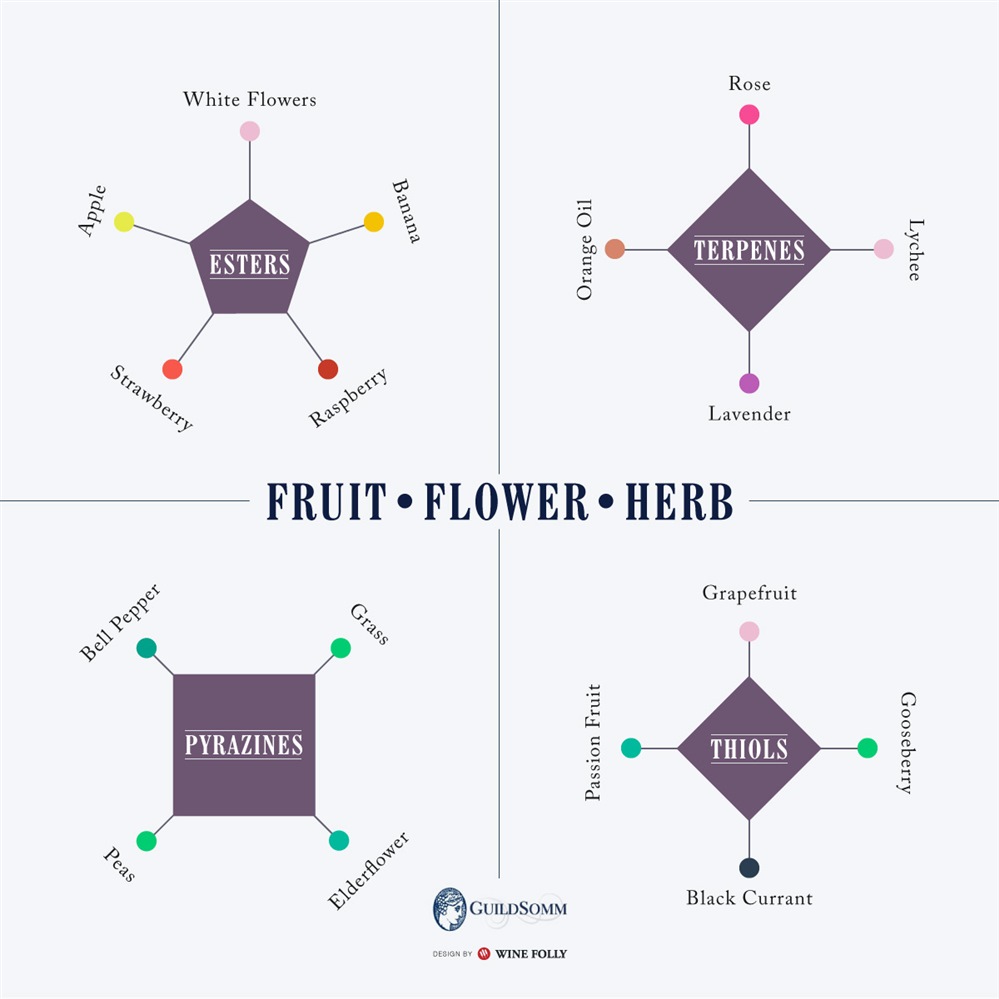“Temo che ci rivedremo nel 2015”: così concludevo il mio piccolo sfogo di due anni fa a proposito di Cheese.
E’ lampante, già lo sapevo che nonostante tutte le mie riserve sulle orde di visitatori poco accorti, sui magheggi di marketing di Slow Food, sulla assurdità delle olive ascolane e della piadina romagnola accanto ai presidi africani, a Bra ci sarei tornato nel 2015.
 E infatti eccomi qui, a raccontare le solite cose e a commentare le medesime immagini; certo, la minestra la si può condire con qualche nuovo aneddoto come quello del gruppo di romani: uno di loro fende la calca per inforcare finalmente una briciola di Stilton, la divora, ne agguanta un altro pezzetto e lo porge ad uno dei compari, urlando: “Aoh, senti che bono”. Risposta dal fondo: “No, no, io mica me fido a magnà stà robba”. E qui sarebbe più dignitoso chiudere, ma non posso non ricordare che, stavolta, c’erano anche i furgoni dello street food.
E infatti eccomi qui, a raccontare le solite cose e a commentare le medesime immagini; certo, la minestra la si può condire con qualche nuovo aneddoto come quello del gruppo di romani: uno di loro fende la calca per inforcare finalmente una briciola di Stilton, la divora, ne agguanta un altro pezzetto e lo porge ad uno dei compari, urlando: “Aoh, senti che bono”. Risposta dal fondo: “No, no, io mica me fido a magnà stà robba”. E qui sarebbe più dignitoso chiudere, ma non posso non ricordare che, stavolta, c’erano anche i furgoni dello street food.
Ci si domanda che ci azzecchino con i formaggi, e pazienza, ma un minimo di controllo su cosa debba essere uno street food ci vorrebbe, ad esempio un cartoccio con alcune (poche) polpettine di carne appena dignitose, venduto a 7 euro di sicuro non lo è.
Chiudo con la mia piccola guida per la sopravvivenza a Cheese 2017:
- se possibile, vai al venerdì (lo so, idea originale…)
- se, come per me, il venerdì ti è impossibile, perlomeno arriva al mattino presto. I banchi aprono alle 10, entro le 9.30 si riesce a parcheggiare quasi in città, evitando l’autobus
- prepara prima una lista di cose che vuoi assaggiare e che ti interessa approfondire e più o meno attieniti a quella, perlomeno per le prime due ore, le uniche nelle quali la folla non è ancora a livelli da prima fila nel prato durante il concerto di Jovanotti. Il cazzeggio indiscriminato ai banchi lascialo per dopo
- evita di metterti in coda per qualsiasi cibo dopo le 12. Mangia prima o moooolto dopo
- ricorda che puoi entrare in macelleria, comperare un metro di salsiccia di Bra, poi andare dal panettiere all’angolo e farti un panino gourmet ad un terzo del prezzo richiesto agli stand
- porta uno zainetto per mettere gli acquisti; riempilo a casa con una bottiglia d’acqua (ho detto bottiglia, non bottiglietta)
- in ogni caso, alle 15 sbaracca: hai mangiato e bevuto come un orso, hai camminato e sgomitato per ore, inutile proseguire
p.s. menzione doverosa per lo stand di Ales and Co: ho bevuto diverse birre, tutte di ottimo livello, ma in particolare una Mosaic di The Kernel strepitosa per quanto era fresca e fragrante.

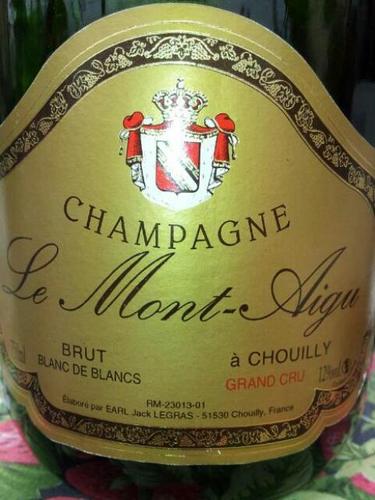


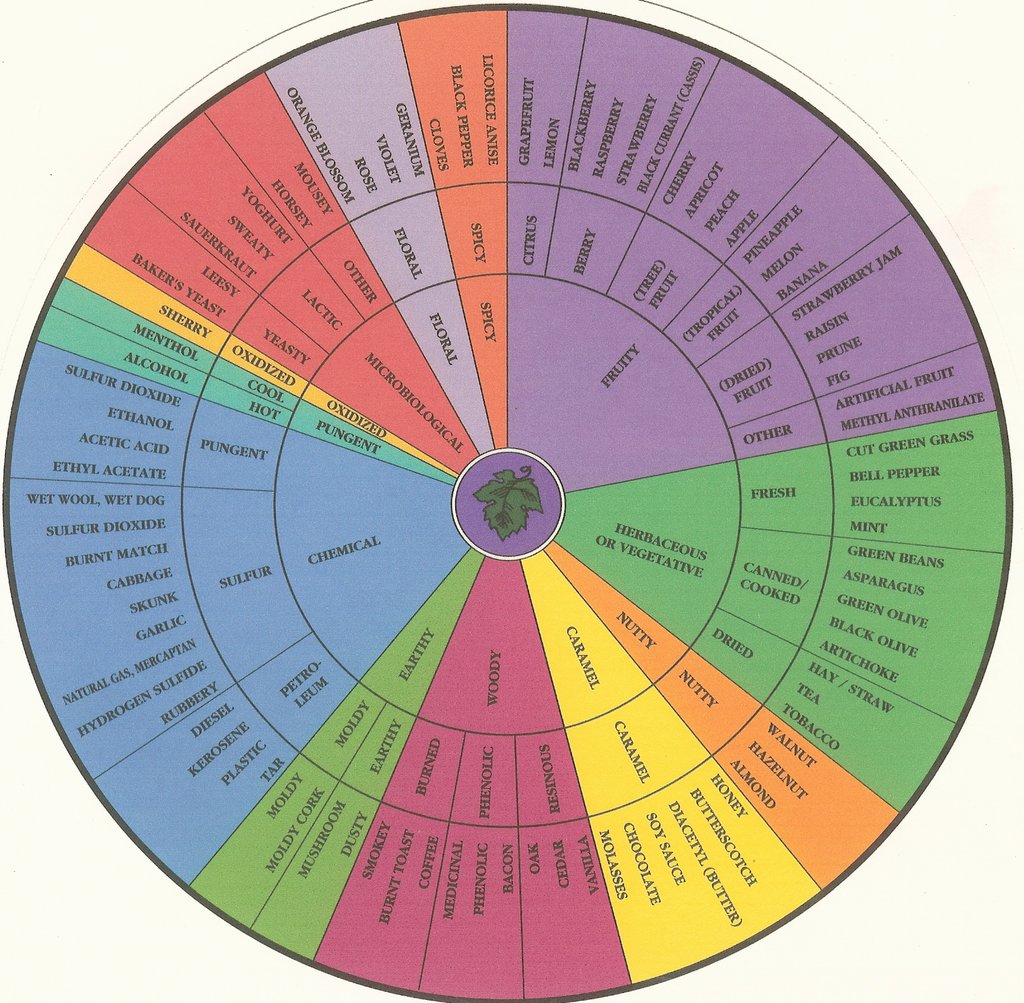 Non smette di ronzarmi nelle orecchie l’ultima frase di questo
Non smette di ronzarmi nelle orecchie l’ultima frase di questo