L’Irish di Genova Quinto è un pub storico del capoluogo ligure, uno dei primi che in tempi remoti (quando l’interesse per le birre di qualità era affare da “pionieri”), ha avuto in carta un numero considerevole di etichette di rilievo.
Da molto non frequentavo il locale, a causa di una serata abbastanza infelice: non tanto per il cibo, che all’Irish è sempre stato un po’ così (del resto trattasi appunto di “pub”, non certo di ristorante), ma soprattutto perché avevo trovato la selezione delle bottiglie abbastanza sguarnita e un paio di spine non proprio in forma, anzi…
Una serata a tema, incentrata sulle birre USA e condotta dal solito Kuaska (potenzialmente molto interessante, visto che in zona le produzioni birrarie indipendenti americane sono poco reperibili) mi ha dato modo di rimetterci piede.

L’ambiente è sempre lo stesso, nel bene e nel male: rustico e caldo, un bel pub, con tavolini troppo piccoli e panche per sedersi. Spine non male, una decina mi pare: ricordo un paio di tedesche, un paio di Brewdog, una Brewfist, una Chimay. Colpevolmente, non ho consultato la carta delle bottiglie.
Tema della cena: birre e cibo USA, ecco i dettagli:
– Pancake alla birra con pancetta con “Morimoto Imperial Pils”, Rogue Ales, Newport (Oregon)
– Cheddar Soup con “Red Giant”, Element Brewing Company, Millers Falls (Massachussets)
– Quaglia al forno con salsa agrodolce (panna, funghi e marmellata di ciliegie) con “Shakespeare Oatmeal Stout”, Rogue Ales, Newport (Oregon)
– Peanuts Butter Cake con “Bam Biere”, Jolly Pumpkin Artisan Ale, Dexter (Michigan)
Considerazioni: la qualità delle portate è sempre quella… direi che in questo senso l’Irish è un locale irrisolto, nasce come pub e immagino abbia competenze culinarie adeguate a quel ruolo; quando tenta qualcosa in più non riesce del tutto.
Nella fattispecie, i pancake erano freddi (per fortuna non la pancetta), la zuppa non male, le quaglie senza infamia e senza lode e la torta al burro di noccioline (come facilmente immaginabile) un mattone colossale.
Servizio da pub: non mi aspetto certo i fronzoli, e vanno bene tovagliette e tovaglioli di carta, ma mettere in tavola una bottiglia d’acqua e un cestino di pane nell’attesa di iniziare (soliti 30 minuti di ritardo, ormai mi sono rassegnato: vale ad ogni serata) mi sembrerebbe poca fatica, così come credo non sarebbe da rovina cambiare le posate con le portate…
Le birre:
Morimoto Imperial Pils: una “imperial pils”, e ti viene il nervoso solo a sentirla, una denominazione del genere. Persino la bottiglia in ceramica, affrescata con caratteri orientali è tanto fighetta da farti perdere la pazienza, poi però vedi gli ingredienti (100% malto pilsner, 100% luppolo Sterling, lievito cieco. Niente strambismi, finalmente!), la osservi, la assaggi e cambi idea.
Dorata, lievemente opalescente, schiuma un poco grossolana; naso ricchissimo di miele di acacia con accenni erbacei. In bocca, dati gli oltre 70 IBU, dovrebbe essere una delle bombe amare che tanto vanno di moda, invece il malto bilancia benissimo e la scia piacevolmente amara resta solo a fine sorso. Che gran connubio malto-luppolo!
Abbinamento strampalato ma funzionante: l’amaricatura robusta riesce a diluire la grassezza della pancetta calda e la dolcezza delle pancakes.
Shakespeare Oatmeal Stout. Birra contraddittoria, sia perché non mi pare troppo in linea con lo stile dichiarato (che vorrebbe una luppolatura più morbida rispetto a questi 69 IBU di Cascade e Perle), sia perché è tanto poco interessante al naso (non si sente quasi nulla, e mai si sospetterebbe l’uso del Cascade: bottiglia non recentissima?), quanto piacevole al palato: caffè, cioccolato e un tocco di affumicato e di salmastro; corpo piacevolmente leggero, si beve benissimo.
Red Giant: boh. Mi è scivolata via senza particolari impressioni. Birra per me molto anonima.
Bam Biere. Delusione della serata, data l’importanza del birrificio; forse anche stroncata da un abbinamento criminale, deciso dalla padrona del locale.
Fermentazione secondaria in botte, con lieviti selvaggi e si sente: lattico, terra, un filo di speziatura, legno. Naso dunque complesso, anche se non troppo fine (il legno la marca molto), pur parlando di birre acide. Il problema è in bocca: molto più semplice e tranquilla, limonosa e corta, troppo corta. La immagino bene per un aperitivo.
Serata interessante e prezzo corretto, considerando le birre non banali e il solito superlavoro di Kuaska.
Articoli correlati:
 Non contando le varie manifestazioni organizzate (male) da distributori e locali, ormai da anni la scena birraria genovese ha subito varie fasi di trasformazioni; si partiva da basi pionieristiche magari piccole ma solide: la presenza in città di un comunicatore di eccezione come Kuaska, l’apporto fondamentale della Compagnia della Birra, che con Massimo Versaci (poi creatore di Maltus Faber) organizzava i primi viaggi in Belgio, i contributi di storici homebrewer (Max Faraggi, Mauro Queirolo), tre locali che in tempi non sospetti investivano in qualità (Irish pub, O’Connor, Pub del Duca)…
Non contando le varie manifestazioni organizzate (male) da distributori e locali, ormai da anni la scena birraria genovese ha subito varie fasi di trasformazioni; si partiva da basi pionieristiche magari piccole ma solide: la presenza in città di un comunicatore di eccezione come Kuaska, l’apporto fondamentale della Compagnia della Birra, che con Massimo Versaci (poi creatore di Maltus Faber) organizzava i primi viaggi in Belgio, i contributi di storici homebrewer (Max Faraggi, Mauro Queirolo), tre locali che in tempi non sospetti investivano in qualità (Irish pub, O’Connor, Pub del Duca)…
 Cinque Euro per un calice di Berlucchi, non ho altro da aggiungere Vostro Onore!
Cinque Euro per un calice di Berlucchi, non ho altro da aggiungere Vostro Onore!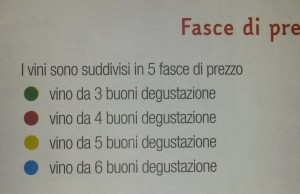

 Ci sono tornato, e posso dire di essere contento di essermi astenuto, ché la cena non è stata affatto disprezzabile.
Ci sono tornato, e posso dire di essere contento di essermi astenuto, ché la cena non è stata affatto disprezzabile. All’ingresso ti danno il libricino, che oltre a tutti i dati sul Franciacorta, dagli uvaggi, al metodo di produzione, passando per tipologie e modi di consumo, riserva una pagina per ciascuno dei 32 produttori, divisa equamente a metà per ognuno dei due vini in degustazione, con nome, millesimo e uvaggio e lo spazio per annotare le impressioni.
All’ingresso ti danno il libricino, che oltre a tutti i dati sul Franciacorta, dagli uvaggi, al metodo di produzione, passando per tipologie e modi di consumo, riserva una pagina per ciascuno dei 32 produttori, divisa equamente a metà per ognuno dei due vini in degustazione, con nome, millesimo e uvaggio e lo spazio per annotare le impressioni.




